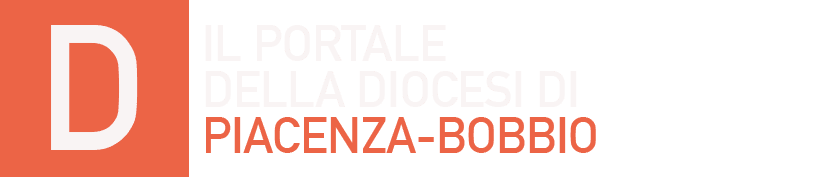La paternità del presbitero alla luce della paternità di S. Giuseppe
S. Giuseppe Operaio – 18.02.21 – Ritiro ai sacerdoti e ai diaconi
Desidero prima di tutto ringraziare il Signore per la vostra presenza, per il vostro ministero, vissuto con passione e dedizione. In particolare la mia riconoscenza va proprio per il modo con il quale siete stati presenti nella situazione di pandemia. Le limitazioni, che hanno provocato tra le sofferenze anche l’isolamento e la solitudine, hanno messo tutti alla prova e nello stesso tempo ci hanno fatto intravedere la preziosità della fraternità e della cura reciproca.
Unisco il mio rendimento di grazie al Signore per avermi chiamato a condividere il cammino con questa Chiesa e con il suo presbiterio. Fin dall’inizio ho respirato sentimenti di vicinanza e di fiducia. Vi chiedo di pregare il Signore che mi doni di esprimere la paternità che mi è richiesta e la fraternità che ci accomuna nella relazione con il Padre del Signore nostro Gesù.
Per questo tradizionale ritiro di inizio quaresima ho pensato di proporvi una meditazione sul tema della paternità, alla luce della figura di S. Giuseppe. Papa Francesco, che ha indetto questo Anno di San Giuseppe, ci ha invitato: “non ci resta che implorare da San Giuseppe la grazia delle grazie: la nostra conversione” (Patris corde, 7). Certo, è la conversione a Gesù, ma ciò accade dentro e per riferimento al nostro ministero e perciò alla nostra paternità. Prendo a prestito alcuni tratti della paternità di Giuseppe (delineati dal Papa) per rileggere anche la nostra paternità e per accogliere degli inviti a conversione.
- Padre nell’obbedienza della fede
La paternità di Giuseppe non è generata dall’ordine biologico, bensì da quello ‘spirituale’: dall’obbedienza della fede. E ciò è immediato considerando la sua vocazione (Mt 1,18-25). In realtà anche nelle tappe successive tale paternità si precisa nella relazione con Dio, che continua a sorprenderlo e a costruire la sua relazione con Gesù (pensiamo alla fuga in Egitto e poi al ritorno e la decisione di dimorare a Nazaret). In questo senso noi ci possiamo ritrovare nella sua esperienza, tutt’altro che marginale nel progetto rivelativo e della salvezza. Perciò non siamo sul piano della fertilità, ma su quello della fecondità.
La paternità (la sua e la nostra) di regola avviene attraverso un travaglio. Non è un processo indolore, anche quella generata dalla fede e nella fede. Il figlio entra nella vita di Giuseppe, affidatogli dal Signore, e lo obbliga ad una fiducia previa, ad un’accoglienza che lo introdurrà progressivamente nel mistero di questo figlio. La medesima accoglienza che gli è richiesta verso Maria (riconoscere il mistero che c’è in lei) deve esercitarla verso il figlio, a cui deve dare il nome.
In ogni caso il figlio non lo si sceglie, tanto più nell’ordine della fede il legame paterno che è chiesto, con una comunità o con le persone che ti sono affidate, lo si deve vivere come dato, consegnato dal Signore. L’obbedienza, che ci colloca dentro uno spazio di relazioni non scelto, alimenta la fiducia che in quella comunità o in quel servizio il Signore dona di maturare la capacità di dono e di oblatività. Ci dona la grazia di esprimere la paternità, la generatività. Che sia una relazione tutt’altro che formale ce lo conferma Giuseppe al quale è assegnato il compito di dare il nome al figlio di Maria: vale a dire di legarsi a quel figlio. Nel nome infatti viene espresso il fatto che egli mi appartiene (nel senso letterale del termine), è parte di me, ma non lo possiedo, non è ‘mio’.
La condizione per rimanere nella ‘nostra’ paternità è di rimanere ancorati in una relazione reale con il Signore. Se è fondata in Lui e rifondata da Lui dentro alle nostre tappe esistenziali e ministeriali, allora la paternità rimane una dimensione vocazionale. Cioè, come un’identità a cui sono chiamato e che è sempre paternità ‘spirituale’, vale a dire generata dallo e nello Spirito Santo. Non è un modo di esercitare il ministero, perché noi diventiamo padri. E il risultato resta sempre una sorpresa. È proprio vero che essa non dipende né da carne né da sangue perché siamo generati e rigenerati in forza dello Spirito Santo.
Tuttavia lungo il cammino è possibile perdere la percezione della nostra paternità (mi sento padre?) e il gusto di esercitarla (sono felice di esserlo? Mi dà pienezza?). In tal caso dovremmo chiederci dove stiamo radicando la nostra vita e il nostro ministero. Non possiamo rischiare di smarrire l’orizzonte del nostro essere e del nostro agire pastorale, quello cioè del Signore che ancora ci sta affidando i ‘suoi’ figli/e e una comunità, acquistati a prezzo del Suo sangue.
Mi permetto di dire che dovremmo vivere la paternità con gioia, perché essa è l’atto di fiducia più grande che ci possa venire dal Signore. Egli ci affida ciò che ha di più caro.
Sono convinto che la consapevolezza della nostra paternità sia minacciata, oltre che dallo smarrimento della relazione viva con il Signore, anche dalle fatiche del ministero e dalla laboriosità delle relazioni. Tante nostre energie vengono assorbite dalle delusioni e dai fallimenti e sottraggono il nostro essere e operare dalla logica della fede. Quando si susseguono incomprensioni, quando prevalgono le tensioni e prende corpo la sfiducia reciproca, se non riconduciamo il tutto ad un discernimento spirituale, rischiamo di farci dominare dai sentimenti di delusione e di ira, di sfiducia e di rinuncia. Su queste reazioni è necessario vigilare e confrontarsi con un padre spirituale. Per un padre naturale le medesime fatiche sono vissute dentro un legame biologico di regola più resistente. Per la paternità spirituale il legame si può sfilacciare sotto i colpi degli insuccessi e dei fallimenti e perciò deve essere recuperata continuamente per poter ripetere: sono miei figli, sono mie figlie.
Possiamo intuire che per noi presbiteri la nostra fede passa anche attraverso il modo nel quale viviamo la nostra vita e il nostro ministero, le relazioni e la cura pastorale.
Nell’ordine della fede c’è anche quell’indicazione data a Giuseppe in sogno: “Alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò” (Mt 2,13). Giuseppe, per custodire il bambino e sua madre, è condotto dal Signore in Egitto e gli è chiesto di ‘restare là in attesa di una nuova indicazione’.
Qui troviamo un duplice aspetto della nostra paternità: il dover partire per un’altra ‘terra’, un’altra comunità, un altro servizio. Agli avvicendamenti appartiene l’esperienza dell’abbandono, che può avere le caratteristiche di un vero e proprio lutto. Un morire che interrompe legami preziosi e gratificanti, spesso costruiti con fatica. Ciò che è chiesto a un padre biologico, di lasciar andare un figlio, per permettergli di intraprendere la propria strada (è una dimensione della generatività), in questi casi per noi il vissuto sembra quasi capovolto. Siamo noi a dover essere lasciati andare. A volte quel legame fatica a trasformarsi, soprattutto quando continuiamo a coltivarlo, non accettando che si sia interrotta la forma precedente delle relazioni. L’altro aspetto che troviamo in questo passo evangelico è che la fede è anche attesa che si aprano strade nuove. È pazienza. È riuscire a stare in ‘esilio’, cioè in una situazione di precarietà e di insofferenza per non essere a casa, fiduciosi che il Signore indicherà un’altra strada. Confidando che lo stesso ‘esilio’ può diventare casa.
- Padre della presenza quotidiana
Giuseppe è descritto come “Padre della presenza quotidiana, discreta e nascosta, un intercessore, un sostegno e una guida nei momenti di difficoltà” (Pc). Per questo, dice papa Francesco, in lui ritroviamo tutti coloro che stanno apparentemente nascosti o in “seconda linea”, eppure risultano decisivi nella vita ordinaria che fa la storia.
La paternità si modella nell’ordinarietà della vita. In quella che Charles de Foucauld identifica con la vita nascosta di Nazaret. Dobbiamo pensare che le azioni più comuni che un presbitero vive appartengono alla cura paterna. Nella celebrazione, nella presidenza della comunità, nella gestione economica, nella testimonianza di vita, nelle relazioni… egli crea i legami profondi che rimangono nel tempo e al di là della frequentazione. Così un sacerdote diventa riferimento per situazioni di difficoltà, diventa padre che accompagna nella fede e nelle tappe della vita.
Come tutte le relazioni e i ruoli sociali, ci deve essere un riconoscimento reciproco: se un padre riconosce in chi gli sta davanti un figlio/a (non solo a parole), è necessario che la stessa cosa avvenga da chi è oggetto di cura. Il prete è riconosciuto come padre mediante la fiducia riposta, il sostegno cercato, il riconoscimento del suo compito di guida, di pastore.
I tasti della paternità si esplicitano nella vasta gamma degli atteggiamenti della sfera affettiva: la cordialità, la vicinanza, la dedizione e la disponibilità…, la capacità di relazioni, la condivisione di un cammino di sequela… che fanno del presbitero un discepolo parte della Chiesa. Ma la paternità si manifesta anche nella capacità di stare di fronte (cfr. PdV n. 16). La guida, il responsabile è anche colui che assicura e garantisce l’oggettività, la normatività. È l’autorità non imposta con modalità autoritative, ma vissuta con l’autorevolezza che è capace di dialogare, di promuovere il confronto, di mostrare pazienza… e, alla fine, di decidere. E tutto questo avviene nella carità, anzi è sua espressione. Anche su questo aspetto è necessario verificarsi: possiamo infatti cedere ad assecondare ogni cosa (privando così la comunità della guida) o, al contrario, di assumere un rigido comportamento autoritario che intimorisce, che allontana, che non riesce a far trasparire comprensione ed empatia. Quando questo avviene l’amore paterno e la cura dell’altro o della comunità non sono percepiti dai più (e non è una questione solo di un ‘brutto carattere’!). Sappiamo bene che l’equilibrio non è facile. Il rapporto con le figure di autorità è assai problematico e l’autorità non è immediatamente riconosciuta, ma questo non può essere motivo di una veloce giustificazione. Lo sappiamo bene: la nostra persona e il modo con cui ci relazioniamo media molto della relazione con il Signore. Noi siamo un sacramento e non dobbiamo dimenticare che nel bene e nel male, anche attraverso la nostra umanità, passa tanta esperienza di fede. È una grande responsabilità.
Ma mi preme ricordare che la nostra paternità è sempre condivisa: con il presbiterio unito al Vescovo. Noi non ci inventiamo presbiteri: riceviamo, grazie alla storia che abbiamo alle spalle, una tradizione di forme nelle quali questa cura paterna si è data. Ed è tipica di questa Chiesa locale: c’è un clero piacentino-bobbiese, che è stato plasmato dalla generazione di sacerdoti che l’ha preceduto. Un po’ come un genitore attinge e si rifà ai modelli vissuti e respirati in casa o nelle figure paterne incontrate, così anche noi sacerdoti.
Questa relazione di comunione, di condivisione solidale prevede un’altra figura affettiva: la fraternità. Non possiamo soffermarci, ma mi basta ricordare che la paternità si deve armonizzare con la fraternità e la figliolanza. Se in noi non sono compresenti l’esperienza di essere fratello e di essere figlio (di qualcuno) si può correre il rischio di essere un po’ mutilati e perciò sbilanciati. Mi riferisco all’ambito umano, ma la stessa cosa vale per il riferimento spirituale: noi rimaniamo figli, fino all’ultimo respiro, siamo fratelli, avendo lo stesso Padre che ci consegna l’uno all’altro. Proviamo a chiederci: io mi sento figlio di qualcuno (dei genitori, del Vescovo, di un padre spirituale)? E ancora, posso dire di vivere la fraternità con qualcuno in particolare (vale a dire un rapporto alla pari)? In caso di una risposta negativa: sto cercando questo tipo di relazioni?
- Padre nell’ombra
Ho già ricordato che noi, con la nostra paternità, rinviamo ad altro, anzi, ad un Altro. Papa Francesco, citando uno scrittore polacco, definisce la figura di Giuseppe come “l’ombra sulla terra del Padre celeste: lo custodisce, lo protegge, non si stacca mai da Lui per seguire i suoi passi. Pensiamo a ciò che Mosè ricorda ad Israele: «Nel deserto (…) hai visto come il Signore, tuo Dio, ti ha portato, come un uomo porta il proprio figlio, per tutto il cammino» (Dt 1,31). Così Giuseppe ha esercitato la paternità per tutta la sua vita.
La nostra paternità è sempre relativa perché attinge dall’Amore del Padre e ad esso rinvia. E, in questo Amore (che è lo Spirito Santo), è capace di generatività. Il Papa, a questo riguardo, cita S. Paolo: «Potreste avere anche diecimila pedagoghi in Cristo, ma non certo molti padri» (1Cor 4,15); e ogni sacerdote o vescovo dovrebbe poter aggiungere come l’Apostolo: «Sono io che vi ho generato in Cristo Gesù mediante il Vangelo» (ibid.). E ai Galati dice: «Figli miei, che io di nuovo partorisco nel dolore finché Cristo non sia formato in voi!» (4,19). La paternità qui si confonde addirittura con la maternità.
Se nella paternità spirituale traspare il legame forte che il pastore ha con la comunità, dall’altro Giuseppe è testimone che in essa non c’è spazio per il possesso, per dei legami che non siano casti. La tentazione di legare a sé, quasi a colmare un vuoto che ci si ritrova dentro, è presente nella vita di noi preti. L’appropriarsi geloso, il non riuscire a gioire del bene fatto dagli altri, come pure l’alimentare un ‘malcontento’ e le mormorazioni verso chi ci è succeduto (non di rado espressioni di un gioco affettivo messo in atto da chi vuole manifestarci la sua stima e il suo legame)… sono facce della medesima tentazione di possesso. E ci consegnano la verità di noi: di una paternità spirituale che deve ancora crescere e maturare. Mi viene da dire: non dobbiamo scandalizzarci di queste nostre povertà, ma neppure possiamo accettarle ed alimentarle. Sono da convertire.
Qualcuno associa la paternità del celibe al genitore affidatario (C. Griffini, “La mia gente, la mia comunità”. La paternità pastorale). Mi sembra una metafora molto interessante e pertinente. A noi presbiteri è chiesto, infatti, per un verso di riconoscere a chi ci è affidato ‘temporaneamente’ una storia che non può essere negata, anzi che va accolta e valorizzata. Per un altro, di stare nelle relazioni pastorali amando con la consapevolezza che la nostra presenza sarà a termine. È proprio vero che un padre compie la propria azione educativa e vive pienamente la sua paternità, solo quando si rende “inutile”.
Alla fine “l’amore che vuole possedere -ci ricorda la Pc- diventa pericoloso, imprigiona, soffoca, rende infelici”. «Tutte le volte che ci troviamo nella condizione di esercitare la paternità, dobbiamo sempre ricordare che non è mai esercizio di possesso, ma “segno” che rinvia a una paternità più alta» (Pc 7).
“Padri non si nasce, lo si diventa. E lo si diventa (…) perché ci si prende responsabilmente cura del figlio” (Pc 7). Allora la paternità è un altro nome della carità pastorale. La possiamo maturare nella misura in cui ci lasciamo rinnovare e convertire dall’Amore di Cristo per la sua Chiesa.
Chiediamo gli uni per gli altri questa grazia nel cammino che stiamo per iniziare uniti alle comunità che ci sono affidate.