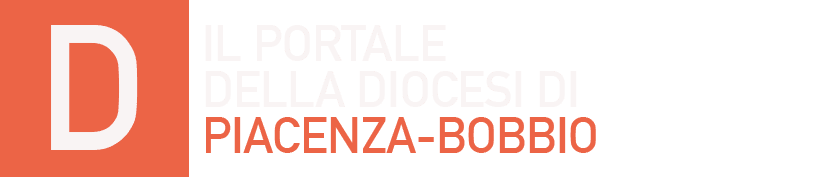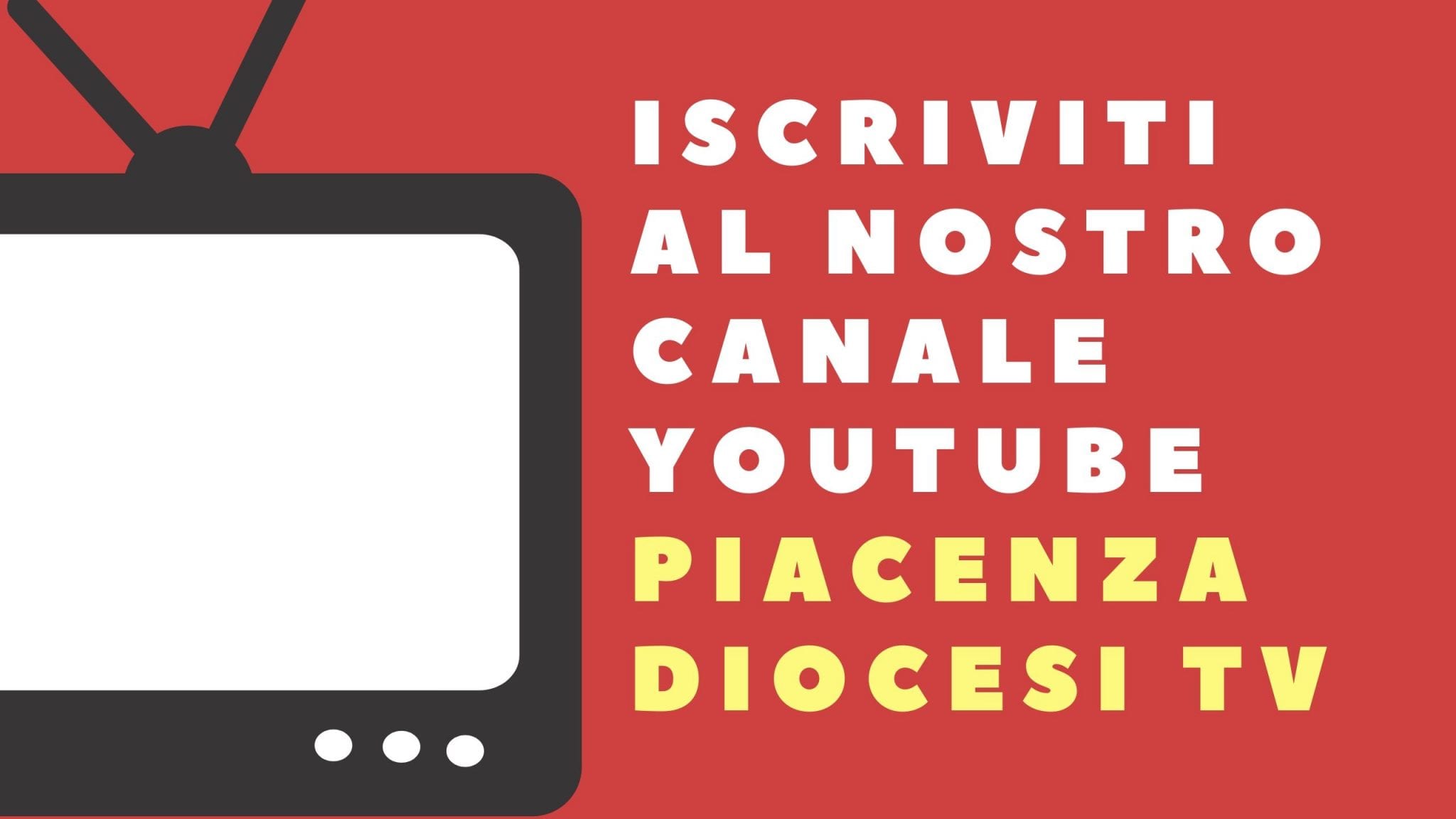Es 20,1-17
Se con Noè l’Alleanza è stabilita con tutto il creato, quella con Abramo coinvolge la sua persona e la sua discendenza: quella del Sinai è l’Alleanza con il popolo. Finalmente, dopo questo tempo nel quale c’è stata mancanza di acqua, di cibo, minaccia di altri re e popoli, litigi e controversie divisive dentro la comunità, si prepara una grande teofania (sua manifestazione): questo Dio ci dirà cosa ci stiamo a fare in questo deserto e ci dirà quanto tempo ci vuole per uscire da questo luogo invivibile… Il cammino è contrassegnato da dubbi, mormorazioni, proteste e lamenti. Si è creata una comprensibile attesa. È il contesto di questa Alleanza.
I dieci comandamenti, come noi li conosciamo, appartengono al nostro patrimonio catechistico e morale. Purtroppo, li abbiamo imparati in una sintesi che ha perso per strada dei pezzi, non secondari, e ha prodotto uno slittamento morale, smarrendo il carattere rivelativo di queste “parole”. Perché così il libro dell’Esodo le chiama: “dieci parole”. Parole che, ascoltate e attuate, permettono -dichiara Jahvé- di custodire “la mia alleanza”. Si tratta di dieci parole che orientano l’agire della vita quotidiana, con le sue molteplici relazioni, a vivere nell’alleanza. È la condizione perché il mio agire parli di Jahvé, di Colui da cui dipende la mia/nostra esistenza. Nella tradizione ebraica il Signore Dio, con dieci parole, crea il mondo. Con altre dieci parole dà esistenza ad un popolo. Siamo in presenza di un gesto creatore.
Allora, se non vogliamo compromettere la comprensione delle ‘dieci parole’, non possiamo omettere l’inizio: “Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra d’Egitto, dalla condizione servile” (20,2). Chi pronuncia queste parole? Sono parole di Colui che ti ha fatto uscire dalla terra d’Egitto: terra di schiavitù. Quindi sono parole che hanno la loro ragion d’essere nell’amore che Egli ti ha dimostrato. Risuonano le parole di S. Paolo: “Cristo ci ha liberati per la libertà! State dunque saldi e non lasciatevi imporre il giogo della schiavitù” (Gal 5,1). Non vengono dopo la liberazione: sono parte del cammino di liberazione. Sono la via per non ritornare nella schiavitù. Non dimentichiamo che la schiavitù mantiene un fascino anche quando ci si è liberati.
Sono Parole pronunciate da Colui che è già il “tuo Dio”, e da Colui ai cui occhi tu sei già “il mio figlio”. Seguirle, non per conquistare la sua benevolenza, il suo amore. È Colui che è già sceso per liberare il suo popolo: è il liberatore (go’el). Le dieci Parole sono anticipate da gesti di amore e di cura.
È sufficiente che guardiamo il testo per capire la sproporzione tra le prime tre parole e le altre sette: esse riguardano la custodia della relazione con questo Dio. Sono il fondamento dell’essere e dell’agire di questo popolo. Qui si radica l’Alleanza. Per motivi di tempo mi soffermerò soprattutto sulle prime tre Parole (dilatate rispetto a quello che abbiamo imparato a memoria).
- “(…) Io, il tuo Dio, sono un Dio geloso (…)”. Potrebbe sembrare un’espressione che non si confà ad un Dio: la gelosia la collochiamo tra i sentimenti da superare, da combattere. Dio si dichiara geloso perché vuole essere unico e non accetta altri dei perché ama la tua libertà che ha conquistato a fatica. L’idolo è ciò che ti rende schiavo: perché è opera delle tue mani. Non prostrarti né servire ciò che è frutto delle tue mani. Ci si inginocchia, si adora e si serve solo Colui che ha fatto te. In Lui riconosci la tua origine e perciò il vero legame. Nella Bibbia la tentazione in ordine alla fede è di ricorrere agli idoli. Che chiedono sottomissione e affidamento, insieme assorbono tempo ed energie. Ci si fa loro schiavi.
È interessante la proibizione di non fare alcuna immagine con ciò che esiste (lassù in cielo, sulla terra, nelle acque e negli inferi): niente può diventare un ‘idolo’. Prima perché con l’immagine si tende a definire Dio, e perciò a possederlo, a fissarne i contorni. Dio non può essere definito: rimane sempre più grande di ogni nostra rappresentazione. Ma poi sembra un gioco: c’è già un’immagine di Dio. L’ha fatta Lui: sono l’uomo e la donna. Immagine che non si deve adorare, ma servire sì!
Il testo apre poi una finestra sul male, che va preso sul serio perché ha conseguenze sulle generazioni che ci seguono, anche se la colpa ricade per un tempo limitato (fino alla terza e alla quarta generazione). Una durata, ma non infinita. A differenza del bene che dura fino a mille generazioni (per sempre!).
- “Non pronuncerai invano il nome del Signore”. In quell’“invano” c’è una relazione interessata, falsata, un Dio chiamato in causa in maniera non sincera. L’uso della fede banalizza Dio stesso e lo rende uno strumento per raggiungere un altro fine. Addirittura, una delle accuse dei profeti è di creare ingiustizia con il paravento della legge o della religione. In questo il Signore si è sempre manifestato severo: lo scandalo dell’iniquità contraddice infatti l’attenzione del Signore per la giustizia e l’attenzione ai poveri. Queste bestemmie, questo agire blasfemo è molto più diffuso e, forse, poco riconosciuto e confessato.
- “Ricordati del giorno di sabato per santificarlo”. Notiamo che il sabato è per tutti: per ogni uomo (anche lo schiavo e il forestiero) e per ogni animale. Il motivo, in questa narrazione della legge, è legato al riposo di Dio al termine della creazione. Perciò il sabato è più delle “feste” come l’abbiamo identificato noi. Infatti, nel sabato (una delle grandi opere di Dio a favore dell’uomo) c’è sia il senso del tempo che del lavoro. Il riposo è umanizzante (siamo giunti a vantarci di non aver avuto né sabato né domenica: essere sempre al lavoro, sempre in attività). Abbiamo introdotto un linguaggio e una mentalità efficientistica e produttiva: coltivazioni e allevamenti intensivi. Animali, terra, piante tutto è soggiogato sotto la legge della produzione. Spinta. C’è una ragione per la quale il sabato comprende tutta la creazione: il dominio, lo sfruttamento non è mai contenuto in una parte, perché inevitabilmente esso si estende… anche all’uomo. Il tempo (nel senso della sequenza dei giorni) e il lavoro (come attività dell’uomo) si ‘salvano’ insieme: il giorno, differente dagli altri, chiama con sé l’altro rispetto al lavoro che appartiene all’umano. L’uomo non è solo attività produttiva. Non è solo efficienza. Se non ci fosse il sabato, il lavoro cadrebbe sotto il giogo dell’idolo. Il sabato ‘purifica’ il lavoro dalle sue tossine! Quel giorno, diverso dagli altri, nel quale il lavoro viene sospeso, era il giorno anche della famiglia, della comunità, delle relazioni gratuite… di Dio. Dio, infatti, si è riposato il settimo giorno (=si è collocato) e consacrando il sabato lo ha reso spazio della sua presenza (che cosa ci è sacro oggi?). Purtroppo, abbiamo perso sempre di più questo giorno di riposo per tutti. È stata una conquista aver messo un limite alle ore di lavoro per l’individuo, ma non si è riusciti a salvare al contempo quello spazio nel quale ci si possa ritrovare insieme. In famiglia. In comunità. Il sabato rappresentava lo spazio dei legami.
- Vorrei concludere introducendo solo le altre parole che, come vediamo, sono senza ‘spiegazioni’. Quasi che le prime tre, essendo il fondamento, avessero bisogno di essere radicate, motivate, quelle che seguono sembrano non necessitare di altro. In realtà proprio su queste Gesù si soffermerà per precisarne le implicazioni (cfr. “è stato detto… ma io vi dico”, Mt 5,21ss).
C’è un’unica Alleanza che prevede le due tavole: Dio stipula l’Alleanza con il suo popolo, attirando a sé le relazioni di ogni giorno. E quando è in gioco l’altro non ci sono condizioni: senza se e senza ma…
C’è solo una relazione che viene associata ad una benedizione: quella che prevede di “onorare il padre e la madre”. Onora significa “dai peso”, valore, importanza… e insieme sostieni. Se si curano le origini (Dio e i genitori) si ha vita: “Solo se riconoscenti e grati del mistero e del bene da cui veniamo, che ci ha nutrito e cresciuto, sapremo cogliere sempre più profondamente cosa sia la vita… e un attimo sarà come mille anni!
Solo se sapremo perdonare i nostri genitori per i loro sbagli, se sapremo prenderci cura di loro anche quando la vecchiaia e la malattia li rendono differenti da come li conoscevamo; solo se sapremo, comunque, essere grati per il dono della vita… allora si “allungheranno” i nostri giorni, non perché necessariamente saranno di più, ma perché potremmo vivere appieno tutto il tempo che ci è dato” (L. Bernardi).