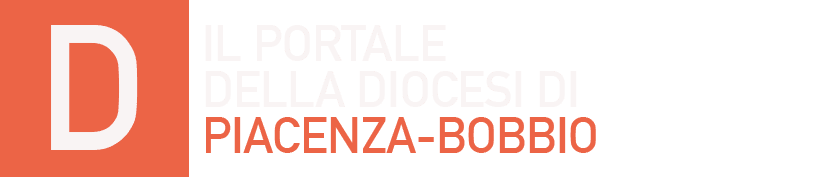Collegio Alberoni
C’è veramente desiderio e volontà di ricominciare? E noi preti siamo parte del mondo che vuole ricominciare? Forse avvertiamo eccessivo questo verbo. Eppure dobbiamo chiederci cosa ci può dire l’ampia partecipazione all’apertura dell’Anno giubilare (ovunque). Almeno riconosciamo un’attesa che potrebbe preludere l’apertura ad una novità. Direi che non possiamo (non dobbiamo) deludere questa attesa né mortificare questo germoglio.
Nel cammino che si è aperto, l’ho citato nella Lettera: Finché c’è speranza c’è vita, papa Francesco dà grande importanza al sacramento della riconciliazione che definisce essere “punto di partenza” per un cammino di conversione. Eppure siamo testimoni del perdurare della crisi di questo sacramento, che attraversa un po’ tutte le generazioni. Forse una certa diffidenza la troviamo anche tra noi sacerdoti, rassegnati di fronte a questo dato. Per qualcuno la soluzione viene proposta nella terza formula (assoluzione generale). Lasciando perdere la percorribilità di tale soluzione, credo sia da privilegiare la ricerca delle cause, per offrire soluzioni plausibili. Poniamoci le domande: è proprio comune la percezione del peccato e il riconoscimento dei peccati? C’è un apprezzamento del sacramento rispetto alla fede? In fondo l’interrogativo è riconducibile al modo attraverso il quale ci raggiunge la grazia di Dio.
L’obiettivo del nostro incontro è approfondire il senso della crisi che interessa l’evidenza e la prassi del sacramento della Penitenza. Vorrei tenere insieme l’approccio teologico a quello pastorale. Per cercare di interrogarci se la nostra prassi pastorale (fatta con le migliori intenzioni e generoso impegno) in realtà non contribuisca a mantenere o accrescere il difficile rapporto già esistente dei nostri battezzati con il sacramento in questione. E più a monte si tratta di vedere se non dobbiamo anche convertire un certo modo (usuale) di pensare il rapporto tra fede e sacramenti.
Non ho la pretesa di dare risposte, ma spero di offrirvi delle piste che possano contribuire alla riflessione da proseguire. Noi siamo consapevoli infatti che il problema è così ampio da non illuderci di trovare formule magiche e facilmente risolutive.
- Alle radici della crisi del sacramento della Penitenza.
a. Crisi del senso del peccato.
Una delle cause del deprezzamento del sacramento della Penitenza e della crisi della sua pratica è la difficoltà a capire cos’è il peccato.
- Va ricordato che il peccato tende, per sua natura, a negarsi e ad autogiustificarsi. Per cui l’uomo peccatore è tentato a minimizzare il peso del proprio atto: cfr. “Cos’è questo in confronto a …?”; “Ho sbagliato, però è capitato perché…”; “Cerco di riparare al male fatto compiendo una buona azione”.
Sotto c’è un’idea di libertà molto diffusa: essa è identificata come la possibilità (infinita) di fare qualcosa. Io, come soggetto, nella mia identità, rimango spettatore, al di qua del mio gesto. Posso passare da una azione all’altra, come se niente fosse accaduto di decisivo per me. Ma c’è da chiedersi: “io sono lo stesso prima o dopo la mia azione?”.
Se poi aggiungiamo la convinzione che Dio possa trarre del bene anche dal male commesso o che comunque la sua bontà supera ogni nostro peccato, allora comprendiamo che il male, per chi lo compie, non è giudicato realmente una cosa ‘seria’.
2
Inoltre abbiamo sotto gli occhi il fatto che si vive una sorta di fuga dalla libertà, quasi un’abdicazione alla responsabilità. Prova ne sia il ricorso ad appellarsi alle varie forme che non dipendono da noi e che condizionano la nostra esistenza e la nostra responsabilità. C’è sempre un colpevole altro da individuare. - È sempre più diffusa la fatica a riconoscere/dare un nome ai singoli peccati (“Non so che cosa dire”). Dovremmo anche in questo caso interrogarci su quanto c’è sotto a questa difficoltà: cfr. “Non è peccato, perché lo fanno tutti!”, e quindi: “Che male c’è?”; “Non ho fatto niente di male!”. Ciò che è giusto/sbagliato viene definito per una legge del negativo; inoltre, sempre di più, ciò che è civilmente permesso e regolato, diventa lecito anche moralmente.
Ne deriva una ricaduta sulla pratica del sacramento in questione: perché andarsi a confessare, se non so che cosa dire? Oppure se posso riprendere di nuovo con un po’ di impegno la mia vita?
b. Crisi del senso della fede (cristiana).
Questa seconda causa non è ugualmente presente nella coscienza ecclesiale (e forse di noi preti). La fatica di comprendere il sacramento della confessione viene espressa nel linguaggio comune con espressioni tipo: “Perché andare a dire i propri peccati ad un prete? Non è sufficiente che me la veda con il Signore?” Mi sembra che, generalmente, noi sottovalutiamo questa difficoltà. Infatti le risposte più comuni sono sulla linea della ‘funzione’ del prete in ordine all’assoluzione o, in una versione più ‘moderna’, in ordine ad un aiuto ‘terapeutico’ o consolatorio che il prete può dare. Aspetti obiettivi, tuttavia l’interrogativo interessa più radicalmente un certo modo di pensare e vivere la fede e, di conseguenza, il valore dei sacramenti.
La fede è intesa per lo più o come un insieme di convinzioni – valori – norme di comportamento…; oppure è identificata con una percezione psicologica che produce un benessere. I gesti religiosi, tra i quali ci sono i sacramenti, sono condizionati da quello che ‘sento’ e dal benessere che producono.
Allora ci si va a confessare per ‘dialogare’ con un prete (simpatico, bravo, in sintonia…); oppure per ‘sentirsi’ meglio, per scaricare la coscienza o per sentirsi a posto.
La crisi non riguarda, in questo senso, solo il nostro sacramento, ma in generale tutti i sacramenti. L’espressione “Che cosa aggiunge il sacramento a…” (al nostro amore; al mio pentimento; alla mia fede…) è usata per esprimere un atteggiamento che non vincola la fede alla celebrazione dei sacramenti. Se il sacramento è «un di più», più o meno consapevolmente esso è considerato un optional. Il riscontro lo possiamo trovare nella morfologia delle nostre comunità: si può essere credenti – credenti praticanti – praticanti non credenti. Senza imbarazzo per nessuno.
- La fede, il perdono e il peccato.
La proposta che vi suggerisco ha sullo sfondo la parabola del Padre misericordioso. Il figlio minore conosce il padre, ha abitato la sua casa, ha assaporato il suo amore. L’esperienza del sacramento della Penitenza è quella del battezzato che ha già vissuto e riconosciuto questo amore. Egli inoltre è la figura del discepolo peccatore, che dice e ripristina la sua fede nel momento in cui ritorna dal padre confessando: “Padre, ho peccato”.
a. L’origine della colpa: il dubbio pratico della fede.
Ci domandiamo: dove nasce il peccato? L’origine del peccato sta nel sospettare della bontà del padre: l’illusione è di trovare la felicità altrove, rispetto alla casa del Padre (Cfr. Gn 3: è la stessa dinamica del peccato di origine). In ogni peccato si manifesta la radice originaria del peccato: il dubbio circa la verità dell’amore di Dio. Questo amore si è compiuto in Gesù: l’amore di Dio ha un
3
volto, una vicenda. Gesù nel momento in cui rivela la verità di Dio, compie la verità dell’uomo. Essa è conosciuta nel momento in cui nella fede noi ci lasciamo interpellare da lui, aderendo a lui nella sequela.
Nel battesimo si avvia quel cammino nel quale progressivamente ci lasciamo condurre da Lui. La vita cristiana è un lasciarsi trasformare da Lui e un radicarci in Lui (cfr. il tema paolino del morire e vivere in Cristo e per Cristo). Nella fede si riconosce la misura dell’amore richiestoci: “Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi”.
Prima che di ordine teorico, il sospetto verso il Signore è pratico: “è possibile questo amore?”, “è difficile viverlo”. Assecondando la percezione che non sia vero perché ‘impossibile’, lo si sostituisce con verità più abbordabili, più su nostra misura. Il peccato è l’insinuarsi, mediante un’azione, un atto, una scelta, del dubbio circa la verità dell’amore di Dio, che è Gesù. Questo è il peccato.
Noi siamo debitori di una visione intellettualistica, per cui siamo in grado di conoscere la colpa commessa mediante una auto-riflessione, dal momento che la consideriamo come infrazione di una norma. Si tende a dar credito al malessere, al rimorso, al senso di colpa provocato dalla nostra azione. In realtà tale sentire rimane ambivalente. Il rimorso, per le caratteristiche della colpa, può essere auto-distruttivo o, al contrario, può nascondersi e affievolirsi dietro un’autogiustificazione menzognera. Fintantoché il figlio minore non mette in atto una decisione, che lo pone nello spazio dell’incontro con il padre, l’ambiguità del rimorso rimane (esempi di persone che pur confessandosi sono vittime del proprio scrupolo). In questo spazio Dio può rivelare il suo amore disarmante e sorprendente. Ed è proprio nello svelamento della dismisura di tale amore, che al figlio appare la gravità del suo peccato. Solo sottomettendosi al giudizio del Padre (che è l’amore crocifisso di Gesù), si dischiude all’uomo la possibilità di scoprirsi peccatore.
Che il peccato non sia un semplice errore o sbaglio ce lo testimonia l’esito della vicenda del figlio minore (“era morto… era perduto…”). La perdita delle ricchezze (=non più recuperabili); della dignità (= “mettimi nel numero dei tuoi servi”); la mancanza di qualsiasi cosa che possa sfamarlo (=la solitudine mortale) indicano in quella scelta il fallimento di sé. Non riesce neppure ad immaginare un futuro. Parlare di colpa/peccato equivale a dire che la libertà ha posizionato il soggetto in una situazione di morte. Nella libertà infatti l’uomo non fa semplicemente qualcosa, fa sé stesso, di fronte a Dio e alla verità del suo amore. Non può riacquistare ciò che ha perduto: il passato non si può più rimuovere, né cancellare (facendo finta che), esso è posto definitivamente. La colpa commessa rimane, come pure le sue conseguenze. Tralasciamo gli esempi che confermano la verità della drammaticità dei nostri atti colpevoli.
b. Il sacramento della penitenza come ritorno alla fede.
Il peccato si presenta come insuperabile? Sì per l’uomo. Tuttavia, mettendo in opera un atto di fede, è possibile un ritorno. Convertirsi non è una semplice presa di distanza dal proprio passato. La conversione diventa vera solo se si concretizza in un ritorno al Padre. È il ritorno alla fede, che riconosce nella casa del Padre un amore abbondante per tutti. In questo modo è riconosciuto quell’amore precedentemente disconosciuto, e verso il quale si era dubitato della sua verità. La memoria dell’amore di Dio (cioè la precedenza dell’iniziativa di Dio, o se vogliamo l’azione dello Spirito santo che testimonia al nostro spirito l’amore che è stato riversato invincibilmente nel nostro cuore) muove la nostra libertà a decidersi per questo amore.
È richiesta la fede, espressa con la libertà, con una sua decisione. Il sacramento è un atto, è un’azione che richiede una decisione. Un ritorno. Non si esaurisce nell’auto-introspezione, nella riflessione critica del proprio agire, cioè in un pentimento tra sé e sé.
4
Ci domandiamo ora: perché confessare le colpe? E perché confessarle davanti alla Chiesa? Sono due interrogativi decisivi nell’attuale contesto, perché come abbiamo visto è carente l’evidenza della necessità di confessare e confessare davanti al prete le proprie colpe. La fede sembra non centrare nulla, o poco, con quanto è richiesto nel sacramento in causa.
- Per dare una risposta al primo quesito (perché confessare i propri peccati?), vorrei richiamare che il verbo confessare è lo stesso usato per dire la fede e per dire il proprio peccato (Cfr. Agostino ne Le Confessioni: Confessio laudis, confessio vitae, confessio fidei). Possiamo così riassumere: non posso dire la mia fede se non riconoscendo: “io sono peccatore”. Per dire questo infatti debbo riconoscere la distanza da quel “…come io…” comandato da Gesù. Lui mi chiede una fede che non è semplice adesione della mente, ma una adesione che parte dal confessare di aver cercato altrove la verità della mia vita. E che cos’è questo se non il mio peccato? Perché il perdono è già stato offerto (è la morte e risurrezione di Gesù), io posso confessare il mio peccato. È nel riconoscere in quella vita donata senza condizioni la verità dell’amore di Dio, che io posso dire: ho peccato. Non basta dire che il Signore ci giudica e ci dice: tu hai peccato; perché mi è richiesto di accogliere quel giudizio dicendo “io sono quell’uomo”.
Ma qualcuno può dire: è sufficiente dire “ho peccato”, perché dovrei accusarmi dei peccati? In realtà non posso raggiungere la mia condizione di peccatore se non riconoscendomi nelle mie azioni libere e responsabili. Solo nel momento in cui io dico la mia colpa essa diventa veramente mia. Provate a pensare l’importanza della parola: non basta pensare una cosa perché essa diventi mia; non basta pensare tra sé e sé di voler bene ad una persona, è necessario che questo sentimento diventi decisione, si esprima. È necessario dire (non solo a parole, ma anche con esse): “ti amo”. C’è bisogno di esprimerla davanti a qualcuno che la riconosca come autentica, dopo averlo fatto percepisco che essa mi appartiene, si è concretizzata, le ho dato forma. - Riguardo alla seconda domanda (perché confessarsi davanti al prete o alla Chiesa?) dobbiamo trovare una risposta su due linee. Innanzitutto è la Chiesa che custodisce e introduce nella verità che è Gesù. Come per il battesimo la comunità è essenziale per accedere alla fede, così è per l’intera esperienza cristiana. Io non posso rinnovare la mia fede se non in essa e grazie ad essa, che me la rappresenta nel rito. La ripetitività del rito mi testimonia e rende presente quell’evento di Gesù di cui non posso mai disporre, ma solo accogliere. Solo a Dio e al suo evento di rivelazione compete l’azione di condanna sul peccato e, con ciò, l’azione di perdono del peccatore. Il giudizio di Dio sulla mia vita non giunge mai in termini immediati, ma sempre mediati dalla Chiesa. Il peccatore cerca nella Chiesa l’unica parola che gli dischiude la chiamata alla conversione. Il prete nel sacramento ha così una duplice funzione: di rappresentarmi quella comunità verso la quale la colpa ha sancito una radicale rottura; e, inoltre, è il testimone e garante dell’autenticità di questa azione verso il peccatore. Egli cioè, nella linea apostolica, testimonia che essa è conforme e fedele all’intenzione di Dio così come si è manifestata in Gesù. Il perdono raggiunge così il peccatore in modo efficace, ripristinando la condizione di figlio. Perdonato.
In secondo luogo quella verità di Gesù interessa la Chiesa in quanto comunità nata dalla Pasqua del Signore. Il riconoscimento della verità dell’amore di Dio in Gesù si manifesta nella comunione ecclesiale. La Chiesa, come comunità pasquale, è il segno vivente della verità dell’evento che annuncia. Il peccato perciò non è semplicemente un disconoscimento personale della fede pasquale, ma, insieme, la smentita della comunione affidata a ciascuno dei battezzati. La fede, che non si dà se non nella sua attuazione storica e perciò nella libertà decisa per quell’amore confessato, ricorda che ogni atto colpevole interessa la comunità pasquale. Non si dà perdono se non nella forma della riconciliazione fraterna. Potremmo soffermarci sul finale della parabola che rimane sospeso fintantoché il figlio maggiore, nel cui cuore si sono impresse le conseguenze del comportamento del fratello, non rientra in casa. Nella fraternità.
5
CONCLUSIONI
Se quanto proposto è vero ci dovremmo chiedere se la nostra ‘educazione’ al senso del peccato insista sullo «sbaglio» o comunque si sforzi a tutti i costi di non dar ‘peso’ a quanto commesso oppure se aiutiamo a far crescere l’importanza delle scelte fatte o omesse (cfr. il linguaggio usato o non usato!).
È da verificare (consapevoli che il compito rimane arduo) il modo di accompagnare la crescita della coscienza. Forse la questione educativa riguarda proprio il riconoscimento del bene/male. Le varie fasce di età esigono una ripresa delle esigenze evangeliche, che non possono più essere proposte esclusivamente con delle norme. Basta la predicazione domenicale? Quali altri spazi recuperare per questo compito che si scontra con una cultura-ambiente troppo spesso ‘pagana’ o post-cristiana? Intuiamo come sia senza esito la mera raccomandazione ad andare a confessarsi.
Mi sembra che la domanda da porci, a livello della fede, è se non soggiaccia anche dentro di noi la separazione tra ‘evangelizzazione’ (=catechesi) e sacramenti. Ci basta verificare su che cosa noi poniamo l’accento: la Parola di Dio, gli incontri formativi… Oppure se il debito della nostra formazione liturgica non si esprima identificando il momento celebrativo con la ‘cerimonia’, rispetto alla quale opponiamo, perché sia accettabile, qualcosa d’altro (la catechesi, attraverso l’introduzione dei vari simboli, l’evangelizzazione, la festa…). Nel caso del nostro sacramento su che cosa poniamo l’accento: sull’assoluzione, sulla grazia… o anche sull’azione del soggetto caratterizzata da quella ‘confessione’? è necessario tenere in unità i vari momenti (conversione, confessione delle proprie colpe- assoluzione- soddisfazione).
Non è forse possibile pensare il sacramento della Penitenza come uno dei luoghi privilegiati per introdurre all’esperienza autentica di fede? Certo ci saranno situazioni in cui ci verrà richiesto di consolare; altre situazioni o momenti nei quali prevale l’utilizzo in chiave psicologica del sacramento. Tuttavia dovremmo aver presente il valore verso il quale tendere per evitare di perdere di vista ciò che il sacramento, efficacemente, è: l’incontro simbolico della rivelazione di Dio, attuata in Gesù Cristo (sostenuta e alimentata dalla Parola di Dio), e la fede del credente e della Chiesa, che coinvolge la libertà del soggetto.