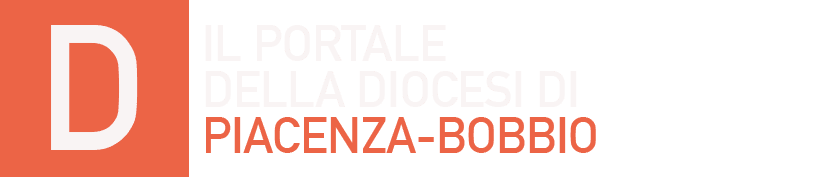Is 50,4-10
Andiamo verso la conclusione del percorso liturgico sull’Alleanza. Già nell’ultima meditazione abbiamo anticipato che il compimento avviene in Gesù, nella sua Pasqua. E il senso e la forza di tale compimento sono raccolti nelle parole che Gesù consegna a noi nell’Ultima Cena: “Prendete, questo è il mio corpo (…) Questo è il mio sangue dell’alleanza, che è versato per molti” (Mc 14, 22-24), riprese ogni volta che celebriamo l’Eucaristia. Dove il termine ‘molti’ dice tutti coloro che vengono alla fede (e perciò c’è un’apertura universale).
Non posso che farlo in forma sintetica, ma dobbiamo ricordare il riferimento delle Scritture che sta sullo sfondo della Passione di Gesù che la Chiesa ha subito riconosciuto chiaramente. Sono alcune pagine profetiche di Geremia e di Isaia. In particolare alcune pagine del libro del profeta Isaia risultarono illuminanti il compiersi dei giorni di Gesù. Si tratta dei cosiddetti “Canti del Servo di Jahvé”: quattro profezie che presentano un Servo di Jahvé (del quale rimane un tratto di enigmaticità: a volte un singolo, in altri passaggi sembra il popolo stesso o un soggetto comunitario). Soprattutto nel quarto di questi Canti, che verrà proclamato nella Azione liturgica del Venerdì santo, viene profetizzato ciò che si consuma nella passione e morte di Gesù. Ed è proprio dalla coincidenza tra la profezia e la vicenda di Gesù che prenderanno forma le prime professioni di fede: “Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture” (1Cor 15,3-4). Cfr. “Per le sue piaghe noi siamo stati guariti” (53,5).
La Liturgia della Parola della Domenica delle Palme propone l’inizio del terzo Canto e su di esso si soffermerà la nostra meditazione; tuttavia vi invito a sostare anche sugli altri Canti, proposti nei giorni della settimana santa.
Nel primo Canto (Is 42,1-9) il Servo è presentato come Colui che il Signore ha scelto per portare la giustizia e la liberazione, ma non con forza violenta, bensì con mitezza e proteggendo e ridando vigore a tutto ciò che è fragile. Nel secondo (Is 49,1-7) viene confermato il compito del Servo, nonostante egli abbia incontrato insuccessi (“Invano ho faticato… invano ho consumato le mie forze”): i destinatari della sua missione addirittura si allargano, non più dentro i confini di Israele, ma verso tutti i popoli (“Io ti renderò luce delle nazioni, perché tu porti la mia salvezza fino ai confini della terra”). Nel quarto (Is 52,13-53,12) il successo del Servo di Jahvé, la sua esaltazione passa attraverso un percorso di violenza subita e di morte (“Il Signore fece ricadere su di lui l’iniquità di noi tutti”… “il giusto mio servo giustificherà molti”… “egli portava il peccato di molti e intercedeva per i colpevoli”).
Soffermiamoci su questo terzo Canto del Servo, che pone l’accento sulla condizione necessaria per vivere la missione che Dio affida: il suo essere discepolo. Nei primi tre versetti del capitolo il Signore, dopo aver annunciato un futuro al suo popolo (Is 49), si lamenta: “perché, ora che chiamo, nessuno risponde?” (50,2). Nelle parole di difesa del Signore si intravvede l’accusa che il popolo gli rivolge: Dio non è in grado di rispettare i suoi impegni. Non ha la forza per liberare. Siamo in presenza di un momento di sospensione.
Ecco, c’è qualcuno che risponde, ed è quasi un sollievo per Dio stesso: la sua offerta ha accoglienza. Ma è motivo di speranza anche per l’umanità: c’è chi corrisponde all’iniziativa del Signore.
Nella prima parte è presentato chi è il servo. Tutto si gioca tra la parola (udita e pronunciata) e l’ascolto. È forte l’espressione “mi ha dato una lingua da discepolo”: quello che dice è qualcosa di imparato, è frutto dell’ascolto. “Perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato”. La parola del servo non attinge ad abilità retoriche particolari, ma è figlia della capacità di ascolto. Ascolto di Dio, e al contempo delle voci che lo raggiungono. Se questo è il primo tratto caratteristico del Servo, la capacità di lasciarsi istruire diventa una priorità per il discepolo. Non mi sembra che questa virtù sia così diffusa, c’è molta presunzione. Prova ne sia che non è facile riconoscere che cosa abbiamo imparato dalle persone, dalle situazioni (anche quelle dolorose come quella che stiamo vivendo). Qualche volta ripetiamo che abbiamo imparato molto, ma siamo in difficoltà ad esplicitare quale sia questo apprendimento. C’è una resistenza all’opera di Dio (“… e io non ho opposto resistenza”), che ha a che fare con l’impedire al Signore di aprire, di forare l’orecchio. Vigiliamo anche sulle resistenze passive, quando cioè opponiamo tutta la nostra passività non facendo nulla. Il segno della nostra adesione è accettare, in definitiva, di essere inquietati, di vincere quella ritrosia a lasciarci mettere in discussione. Lasciar fare a Colui che ci ha dimostrato fedeltà, amore. Non basta non opporre resistenza, aggiunge: ‘non si è tirato indietro’: è risposta generosa. È partecipazione creativa, in prima persona: è mettersi in gioco, senza calcolo. E’ evitare l’attendismo.
Notiamo che chi plasma è il Signore (“mi ha dato una lingua da discepolo” … “ogni mattina fa attento il mio orecchio” … “mi ha aperto l’orecchio”). Ogni mattina il discepolato ricomincia, così come ogni giorno. Ogni giorno, direbbe l’esperienza dell’Esodo, dobbiamo uscire fuori dell’accampamento per raccogliere la manna per quel giorno.
La ragione dell’ascolto è di indirizzare una parola allo sfiduciato, sembra il compito primo del Servo: la fiducia (l’abbiamo scoperto anche quando c’è stata la prima crisi economica) è alla base della convivenza, dello stesso sviluppo economico.
Quali sono le parole di speranza che sappiamo pronunciate? Ma quelle vere, che non ci cadono dalla bocca mentre le stiamo dicendo? Quali sono le parole di fiducia che si aspettano le persone che ho vicino? Quali parole io mi aspetto quando sono in difetto di speranza? Nessuno può presumere di non passare per momenti di crisi… anche di fiducia. Ed è molto interessante (e vero) che la fiducia ha bisogno di una parola che promette, che apre il cuore, che mostra un futuro possibile. Ed è possibile perché in quella parola ci sei tu, con la tua credibilità. Nel futuro che offri ci sei anche tu. A condizione che tu dimostri di saper ascoltare, prima di parlare. Deve risuonare come parola autentica e credibile per raggiungere il cuore dello sfiduciato. Con la tua fede puoi rianimare nell’altro la fiducia nel domani.
Quasi improvvisamente il rapporto intenso tra Dio e il suo Servo si interrompe: sembra che il non tirarsi indietro porti ad una situazione di violenza. La risposta obbediente (alla lettera ciò che sta dentro un ascolto profondo e disponibile) al male e all’ingiustizia è stare con fedeltà. La resistenza al male è figlia dell’ascolto, della comunicazione di Dio, nella Sua Parola. Il fatto di avere una presenza di Dio sicura e rassicurante permette di non provare vergogna, di avere una faccia resistente come pietra, di non essere annientato. La forza del male va oltre il dolore fisico: è minaccia alla dignità della persona, è annientamento dell’identità, è confusione, disorientamento. E i versetti successivi a quelli proposti dalla liturgia confermano la capacità del Servo di non essere travolto dentro alle accuse ingiuste.
La voce del Servo del Signore è da ascoltare, per imparare ad affidarsi al Signore.
Le alleanze che si sono succedute, tutte originate dall’iniziativa appassionata ed incondizionata del Signore, sono arenate sull’incapacità di corrispondere dell’uomo e del suo popolo. Ma di fronte all’apparente fallimento del legame di amore che Dio desidera instaurare con ciò che ha creato, Egli rivela e attua la sola condizione per dare compimento a questo sogno di salvezza. L’inno che troviamo nella lettera ai Filippesi concentra il compimento dell’Alleanza nella persona di Gesù, Servo di Jahvé. Gesù Cristo, pur essendo nella condizione di Dio, svuotò sé stesso; “assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini” si fece “obbediente fino alla morte e a una morte di croce” (cfr. Fil 2,7-8). Ecco come finalmente Dio riesce a superare il fallimento: unisce in sé, nella persona del Figlio che si fa uomo, l’iniziativa/l’offerta e la risposta. Si compie così, in una esistenza che compie la condizione di Figlio, l’Alleanza. E in Lui, cioè uniti a Lui nella fede, finalmente l’Alleanza eterna diventa realtà, salvezza. Per tutti e per ciascuno.